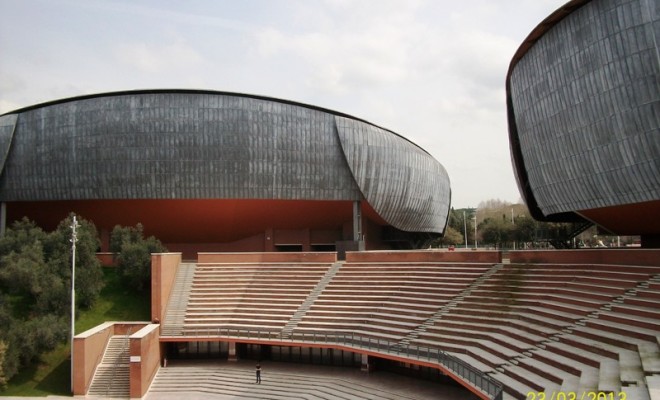Il lavoro, la dignità, l’umanità perduta in “Spaccapietre” dei fratelli De Serio
La dignità del (e nel) lavoro: il tema, in assoluto, da analizzare, di cui parlare, soprattutto da difendere. E il cinema, in questo senso, può fare tanto: per svelare universi poco noti, ciò che ci sta accanto, ma che non vogliamo vedere. Può documentarlo, ma anche osservarlo facendo arte, come è proprio del cinema e di tutte le altre arti: mescolando tragedia e poesia, usando la metafora per parlare di un mondo alla deriva, di un’umanità persa. Usando sguardi nuovi, stili propri, in cui l’intensità della messinscena si unisce a quella dei silenzi densi di significato; in cui poche parole sono brevi sottolineature di immagini tra realtà, durezza ed emozione. E’ quanto riescono a realizzare i fratelli Gianluca e Massimiliano De Serio nel loro “Spaccapietre”, presentato in concorso alle Giornate degli autori, alla Mostra del cinema di Venezia.
Il mondo del lavoro, ma più in generale il mondo, l’umanità, vista con gli occhi di un bambino. Un bambino che fa domande, ma che in fondo non se ne fa più. Che guarda il mondo, come nella scena iniziale, a testa in giù, perchè il mondo va al contrario. Gli uomini trattati come bestie, per pochi euro che dovrebbero essere il compenso di giornate passate nei campi, sotto il sole o a spargere veleno tra le coltivazioni, con protezioni improvvisate o di seconda mano. Migranti ed italiani, uniti dal bisogno e dal vivere in baracche: scene viste nei tg o in documentari, ma che subito dimentichiamo. Qui lo sguardo, però, è dall’interno, è l’umano che resiste e quello che per necessità si adegua, è la pietà che non cessa e quella che per un attimo si allontana, per poi divenire rabbia e vendetta.
Il filo conduttore è quel bambino, la cui madre è morta di fatica in quel campo in cui sarà costretto a lavorare, aiutando il padre, licenziato da una cava dopo un incidente sul lavoro. Il loro rapporto, la dolcezza di quella simbiosi in cui i ruoli sembrano confondersi, ne fa degli estranei, degli esseri alieni a quell’universo di sopraffazione, violenza, degrado, intimidazione. Il loro affetto, la loro cura reciproca, il ricordo della madre e moglie li unisce al di sopra di tutto: ma senza eccessi, bensì con una verità ed una naturalezza che si scontra, che cozza con l’esterno in cui però sono costretti a vivere. Così è anche il rapporto con l’amica della madre, che conosceranno nella tendopoli, o con il giovane immigrato che laverà le ferite del piccolo Antò.
“Spaccapietre” racconta, fa entrare in un’atmosfera di reale senza essere cinema del reale, senza essere solo descrittivo, ma restituendo sensazioni, emozioni, crescendi e mutamenti di questa umanità che scende negli inferi e se ne fa ingoiare, ma che ancora vuole sperare, come la corsa finale potrebbe suggerire. Un cinema non catalogabile in definizioni, in ristrette categorie, che evidenzia sicuramente uno stile proprio dei registi e che è supportato dalle interpretazioni: quella del giovanissimo protagonista Samuele Carrino e quella di Salvatore Esposito, che gioca in sottrazione, tratteggiando la figura di un padre ed uomo sensibile, che seguirà un mutamento quasi scritto nella sua storia, come in un ineluttabile destino che ricorda le tragedie greche, in uno scontro che si ripete tra umanità e sopraffazione.